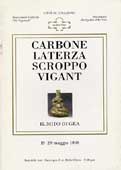
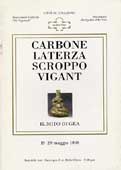
In nome di Gea
Si sente ancora nominare dopo decine di secoli; e anche nel Terzo Millennio
già vicmissimo il suo nome continuerà a sentirsi pronunciare
come sedimento etimologico di un significato, che dalla risonanza cosmica
del mito greco spazia fino ai linguaggi comuni o scientifici dell'attualità:
Gea, o Gè oppure Gaia secondo altre formulazioni, rievoca una figura
"fossile" e insieme vivente della terra investita di divinità
ogni volta che si adopera, per esempio, la parola "geografia". E
quando la titolazione di un dipinto si richiama alla mitica pensabilità
di un'origine "terrestriale", il termine di riferimento suggerito
risulta visibilmente impegnativo, per la molteplicità dei modelli etnologici
ipotizzati come per la pregnanza simbolica delle loropossibili riattivazioni.
Nella versione più statisticamente desunta dal labirinto del pensiero
mitico antico, Gea è la prima e primordiale forma divina emersa dal
Caos, la Terra che genera poi il proprio personaggio complementare, Urano,
ossia il Cielo, e che con lui genera quindi i Titani, i Ciclopi e gli Ecatónchiri
giganti dalle cinquanta teste e cento braccia.
Una delle Titanesse, fra l'altro, ha molto a che vedere con le ani: Mnemósine,
dea della memoria (e sorella di Crono, il Tempo, padre di Zeus) è infatti
la madre delle nove Muse, figlie anche del proprio nipote Zeus. Ma Gea è
inoltre madre di altri esseri avuti da Ponto e da Tartaro, padre del mostro
Tifone dalle cento teste di drago, che a sua volta è padre (insieme
alla sposa Echidna, per metà donna e per metà serpente, uccisa
poi da Argo, il gigante dai cento occhi, omonimo di quell'Argo, figlio di
Frisso e di Calciope, che costruì e diede il proprio nome alla nave
degli Argonauti) di Cerbero, delle Arpie, della Chimera, della Sfinge e di
ulteriori mostri mitologici. Affine al nome di Gea è quello di Geb,
il dio-terra egiziano primordialmente unito alla dea-cielo Nut prima della
loro separazione ad opera del dio-spazio-vuoto Shu: nel mito greco, invece,
Gea (la Tellus Metter dei romani) è la dea, e il Cielo, Urano, è
il dio, con un rovesciamento delle posizioni cosmogoniche rappresentative
della complementarità creatnce dei ruoli. Il passaggio dall'indifferenziato
al differenziarsi, il mutamento dall'indistinto al dialettizzarsi dei concetti
mitici, la svolta dall'unità indefinita alla interazione dinamica generano
un articolarsi di cognizioni che è anche un moltipllcarsi di immagini
attraverso le affinità selettive della natura come dell'immaginario.
Mnemósine ha molto a che vedere anche con le scienze, e le sue figlie,
passate da tré a quattro e a nove, riguardano anche l'astronomia e
la storia. Come Terra Madre, Gea per Eschilo ("Coefore") "partorisce
tutti gli esseri, li nutre e ne riceve di nuovo il germe fecondo"; e
per Esiodo ("Teogonia") partorisce gli dèi, che poi la imitano,
imitati a loro volta dagli uomini e infine dagli animali: il repertorio mitico-rehgioso
tradizionale viene da lui sistematizzato esplicitando nei nomi stessi il bipolarismo
aperto alla divinizzazione come alla lettura dell'ambiente fisico, alla tensione
archetipale come alla percezione cosmica, ali'estensione simbolica come al
senso naturale dell'esistenza tra la vita e la morte. Anche solo questo rapido
zapping nell'ipertesto di Gea, questa abbozzata navigazione nella rete dell'antropologia
sacra e insieme profana, questo "volo" probabilistico nel labirinto
della mitologia mediterranea, possono esemplificare la molteplicità
ricca e contraddittona di dati a cui ci si intende riferire, virtualmente,
quando i titoli dei quadri alludono in modo esplicito al nome di quella divinità
della Terra. Guardare alla struttura mitica e insieme naturale di Gea (e fare
di questa referenza il motivo avvincente e vincente di una interazione espositiva
fra quattro esperienze pittoriche) non obbliga però, come è
ovvio, a addentrarsi nella complessità intricatissima e problematica
dell'argomento in questione. Il libero gioco interattivo fra il mito di Gea
e le visioni artistiche contemporanee può innescarsi non meno emblematicamente
come espansione prioritaria della visibilità oppure dell'immaginazione
quotidiana sugli estremi echi mitologici, e quindi più come presa di
distanze che come reimmersione "mitopoietica": come senso terrestre,
planetario e diretto, dunque, lontano da mediazioni filologiche. Così
Sara Carbone sceglie, ad esempio, la pianta, dalle radici alle fronde,
come segno di vita che scaturisce dalle viscere azzurrate del prato: "Gli
alberi", scriveva Rabindranath Tagore, "sono l'estremo sforzo della
terra per parlare al cielo". Allegoria possibile di rapporti fra mondo
ctonio e mondo uranico, l'immagine conserva peraltro la leggibilità
immediata dell'evento naturale che predomina, del resto, in questo modo di
guardare. E giustamente il nome di Gea viene posto fra parentesi dal trionfo
della vegetazione. Lia Laterza mette in scena l'eruzione vulcanica
che diventa "II furore di Gea" e anche, si potrebbe aggiungere,
di un figlio di Gea e del Tartaro come Tifone o Tifeo, che avendo tentato
di detronizzare Giove venne poi vinto dal dio supremo dell'Olimpo e sepolto
vivo sotto l'Etna, da cui secondo Ovidio ("Metamorfosi") "feroce
espelle terra dalla bocca e vomita fiamme": l'aureola di luce tipica
di questa pittrice ne evidenzia magma e lapilli, mentre in altri acrilici,
di Gea, vengono alla ribalta l'amore e i tesori. Egle Scroppo assembla
per Gea un'immagine composita e brillante, dove un impianto araldico di ascendenza
postcubista e di confluenza affabulatoria si infittisce di frammentari volti,
presenze immaginali, animali di cielo e di terra, in un inesauribile cantico
della creatività generatnce e trionfante. L'ordine geometrico della
stilizzazione tempera l'apparente caoticità esplosiva della vita, e
ne tempra la favolosa fantasmagoria scaturita dalla natura stessa della cultura
iconologica: cosmo, in greco, significa ordine. Maria Luigia Vigant
percorre m vane direzioni un repenono cosmico dove, fra terra e cielo, non
c'è interruzione di continuità. Tutto fa pane di una natura,
che anche nei confronti della pittura e dell'ambiente non conosce soluzione
di continuità. Il quadro può diventare installazione in un linguaggio
che di Gea, intesa come mito tellurico delle origini, serba lievi e appena
disincantate memorie. Alla sua interazione con Gea si addice quindi un punto
interrogativo, estensibile alla pittrice, "Gea" delle proprie opere.
E questa ipotizzata traslazione di sensi dal mito "geomorfico" della
natura primigenia al sito materico (e "materno") della pittura mediato
dalla immagine mitizzata dell'anista può riguardare inoltre le altre
pittrici che espongono insieme, e anche il significato stesso della loro mostra
in cui, insieme, pariteticamente "si espongono": dove l'interazione
fra i dipinti e il mito di Gea diventa simultaneamente, e più che mai,
metafora di un mito remoto dell'ano sempre più lontano dai modelli
di vita anefatta del presente. Sempre, ancora, "m nome di Gea".
Lucio Cabutti